Introduzione
Ogniqualvolta dobbiamo affrontare un caso clinico le nostre scelte procedurali devono sempre basarsi su un’attenta diagnosi. Il termine diagnosi deriva dal greco διαγιγνώσκειν (diagignóskein, capire), formato da διά (diá, attraverso) e γιγνώσκειν (gignóskein, conoscere): per identificare, in prima visita, l’eventuale presenza di una patologia nel cavo orale di un paziente dovremo avvalerci di tutti i mezzi possibili, attraverso i quali potremo poi stilare un piano di trattamento definitivo.
L’odontoiatra deve effettuare sempre una visita diagnostica completa, la quale è composta da un esame obiettivo, dalle radiografie endorali e, se necessario, da un sondaggio parodontale e dall’analisi dei modelli studio.
Una volta giunti alla diagnosi, che è una e unica, potremo poi formulare diversi piani di trattamento. In questo articolo presenteremo il caso clinico di una riabilitazione completa affrontata esclusivamente mediante un intervento conservativo, con restauri diretti e indiretti in composito, seguendo un approccio orientato dalla ricerca clinica e scientifica, che deve guidarci nelle scelte operative, dettate da precise linee guida. Tale approccio mira al ristabilimento dell’integrità estetica, strutturale e funzionale dell’elemento dentale, minimizzando il rischio di recidiva cariosa attraverso il controllo di tutte le possibili variabili in grado di inficiare il risultato ottenuto con il nostro intervento.
Il caso clinico step by step
Il caso clinico presentato nell’articolo si riferisce a una ragazza di 21 anni che si reca nel nostro studio per un controllo generale. L’ultimo risaliva a 2 anni prima ed in seguito a questo erano state effettuate tutte le ricostruzioni in composito che si possono apprezzare dalle immagini (Figg. 1, 2a,b). L’unico disagio riferitoci dalla paziente in fase anamnestica era la frequente rottura del filo interdentale durante le quotidiane manovre di igiene orale; igiene che, nonostante le difficoltà incontrate della ragazza, era di ottimo livello, come è possibile apprezzare dalle fotografie che abbiamo effettuato in prima visita.
L’approccio diagnostico ha previsto l’esecuzione di un esame obiettivo, di fotografie, di 2 radiografie bitewings (che la paziente riferisce di non aver mai eseguito precedentemente), di un controllo parodontale e di un’ortopantomografia per avere una visione globale delle arcate dentali e delle strutture ossee adiacenti (Figg. 3a,b, 4a,b): la compilazione di un piano di trattamento, anche quando ci troviamo di fronte a un caso che riteniamo risolvibile in maniera totalmente conservativa, non può mai bypassare una valutazione completa dell’intera cavità orale. Come è stato possibile riscontrare dall’esame clinico la paziente presenta numerose carie sia primarie, occlusali o interprossimali, che secondarie, dovute a infiltrazione a carico dei restauri in composito incongrui.
Dalle bitewings emergono numerose carie interprossimali e, data la recente esecuzione dei restauri, capiamo di trovarci di fronte a una riabilitazione low-quality, associata peraltro ad un danno iatrogeno. Da qui emerge l’importanza, non solo ai fini ecm, di un aggiornamento continuo, che in questo caso avrebbe potuto consentire l’ottenimento di un risultato più dignitoso e rispettoso dei principi della deontologia medica.
Ora andiamo ad analizzare, quadrante per quadrante, step by step, quali sono state le nostre scelte terapeutiche e come abbiamo finalizzato in maniera conservativa questa riabilitazione.
Quadrante 1
Nel primo quadrante rileviamo restauri con margini di chiusura imperfetti e infiltrati su 16 e 17 e carie interprossimali coinvolgenti tutti gli elementi dentari (Fig. 5).
Isoliamo innanzitutto il campo con la diga di gomma, presidio fondamentale per poter garantire un ottimale sfruttamento delle proprietà dei materiali compositi grazie al controllo sia della saliva che dell’umidità del respiro, e rimuoviamo i vecchi restauri, inizialmente solo su 15 (che si presentava iperemico) e 16 (Figg. 6, 7). Possiamo apprezzare che la carie è di tipo penetrante e ha comportato una reazione dell’organo pulpo-dentinale con formazione di dentina terziaria.
Per poter conservare la vitalità di questi elementi rimuoviamo integralmente il tessuto cariato, sino ad ottenere una superficie che una volta disidratata sia apparsa priva di aree opache, utilizzando delicatamente gli strumenti rotanti, senza pressioni eccessive onde evitare surriscaldamenti. Dopo aver rimosso il tessuto infiltrato da batteri procediamo rifinendo la cavità, la cui forma sarà strettamente legata a quella della lesione cariosa per minimizzare il sacrificio di tessuto dentale sano.
La rifinitura marginale viene eseguita con frese diamantate a grana fine per creare margini cavitari che siano il più omogenei possibile, eliminando al contempo i prismi di smalto non sostenuti: i margini occlusali possono essere bisellati mentre i gradini cervicali devono essere rifiniti con un margine netto e ben lucidati, anche mediante l’ausilio di un tagliasmalto. Terminata l’esecuzione della forma cavitaria è dunque possibile procedere con le ricostruzioni dirette in composito degli elementi.
Le procedure adesive vengono eseguite utilizzando esclusivamente un sistema three step, concettualmente il più datato ma al contempo più testato e considerato a tutt’oggi, da molti ricercatori, il gold standard: questo prevede un total etching con acido ortofosforico, applicato sullo smalto per un totale di 30 secondi, e di 15 sulla dentina. Dopo aver risciacquato l’acido e asciugato la dentina (senza disidratarla) con un delicato soffio d’aria, si procede all’applicazione del primer in più apporti, che va soffiato con aria sino ad ottenere una superficie dentinale lucida. Viene infine apportato con un pennellino, o con un brush, il bonding, che dev’essere soffiato delicatamente per rimuoverne gli eccessi e per poterlo distribuire in maniera omogenea sulla cavità, che verrà poi polimerizzata per 40 secondi.
Per le ricostruzioni ci affidiamo ai moderni i compositi nanoibridi (Fig. 8) che, grazie ad una ridotta contrazione da polimerizzazione, limitano la microinfiltrazione e la recidiva cariosa e presentano ottime caratteristiche in termini di lucidabilità. Tali materiali presentano infatti eccellenti proprietà fisico-meccaniche: sono altamente caricati, possiedono un modulo di elasticità simile alla dentina (10-26 GPa), presentano ottime caratteristiche superficiali e un comportamento all’usura similare a quello dello smalto pari a 10-50 micron all’anno.
Terminati i restauri su 15 e 16, eseguiti quelli su 13, 14 e 17 (Figg. 9, 10).
Quadrante 2
Nel secondo quadrante (Figg. 11, 12) poniamo l’attenzione sugli elementi 24 e 25: sul primo sono evidenti i ripetuti colpi di fresa inferti sulla parete distale, sul secondo è stata eseguita un’otturazione debordante e priva di sigillo marginale. Ripuliamo gli elementi dentari e ci troviamo di fronte a grosse cavità (Fig. 13): a questo punto siamo davanti a un bivio e dobbiamo decidere se eseguire restauri diretti o indiretti. Ma quali sono i criteri decisionali per discriminare tra le due opzioni?
Partiamo dal concetto che qualunque trattamento si effettui, è sempre da preferirsi la tecnica meno invasiva e meno complessa in relazione alle capacità cliniche dell’odontoiatra.
La tecnica diretta è sicuramente meno invasiva, meno costosa e prevede una sola seduta, ma ha lo svantaggio legato all’ottenimento di un buon aspetto morfologico occlusale e interprossimale in presenza di cavità ampie e al difficile controllo della contrazione da polimerizzazione, possibile mediante microincrementi e una tecnica di stratificazione mirata a contrastare gli effetti negativi legati al C-factor. La tecnica indiretta consente di ottenere una migliore anatomia e di minimizzare gli stress da polimerizzazione, ma richiede una divergenza delle pareti e conseguentemente un maggior sacrificio di tessuto dentale sano, necessita di due sedute e ha un maggior costo legato anche ai processi di laboratorio. La recente ricerca scientifica dimostra che il comportamento a lungo termine dei due diversi restauri è sovrapponibile ma va anche ricordato che, indipendentemente dalla tecnica scelta, la predicibilità del successo, e quindi la durata dei restauri, è anche strettamente legata all’accuratezza di esecuzione ed al rispetto di protocolli e indicazioni. Nel caso clinico che stiamo affrontando optiamo per una tecnica diretta. Per fare questa scelta utilizziamo di routine uno spessimetro per misurare lo spessore amelo-dentinale delle cuspidi. Il valore limite di tale spessore, nel dente vitale, è nell’ordine di 1,5-2 mm, in quanto al di sotto di tale valore la parete sarebbe esclusivamente sostenuta da smalto e non sarebbe prognosticamente affidabile (Fig. 14). Ricostruiamo quindi ogni dente a partire dalle creste marginali (Fig. 15) mediante il posizionamento di matrici sezionali, cunei e anelli divaricatori per curare bombature e altezze dei punti di contatto. Trasformiamo cosi le seconde classi in prime (Fig. 16) e non ci resta che modellare gli elementi incremento su incremento fino a ricostruire il tavolato occlusale (Figg. 17, 18).
embedImagecenter("Imagecenter_2_703",703,"small");
Quadrante 3
Nel terzo quadrante la presenza di pareti smaltate sottili e non sostenute negli elementi 36 e 37 una volta ripulite le cavità cariose (Figg. 19, 20, 21), ci fa orientare in direzione di una riabilitazione indiretta mediante intarsi in composito, mentre ancora diretta per 34 e 35.
Dopo aver rimosso da 36 e 37 il tessuto carioso eseguiamo il build-up adesivo (Fig. 22). Quando decidiamo di affrontare un caso clinico mediante un approccio indiretto effettuiamo il build-up di routine, poiché quanto più gli spessori e le dimensioni della cavità sono uniformi, tanto meno gli intarsi sono soggetti a fratture e la luce della lampada polimerizzatrice può raggiunger meglio il cemento fotopolimerizzabile. Inoltre il build-up protegge e sigilla la dentina, evitando fenomeni di ipersensibilità, colma i sottosquadri, evitando sollecitazioni del materiale da impronta all’interno di essi, e funge da ammortizzatore, soprattutto se l’intarsio viene realizzato in ceramica.
Altro motivo per realizzare il build-up è la rilocazione del margine cervicale, che si rende necessaria tutte le volte in cui il gradino cervicale abbia una posizione sfavorevole per il posizionamento della diga, per le impronte e per la cementazione. Il margine rilocato dev’esser considerato come un ausilio per l’effettuazione delle successive manovre cliniche, ma è imprescindibile che esso debba esser realizzato a campo isolato: qualora non fosse possibile, la rilocazione dev’esser effettuata mediante un allungamento chirurgico di corona clinica. Una volta terminato il build-up adesivo vengono eseguite le preparazioni per le cavità idonee ad alloggiare il futuro intarsio, che dovranno presentare pareti divergenti di circa 6-10°, finitura dello smalto a margini netti, angoli interni arrotondati, pareti residue sufficientemente robuste, pareti con spessore inferiore di 1,5 mm abbattute e interessate da una ricopertura cuspale (Fig. 23).
Rimossa la diga viene immediatamente rilevata, mediante un silicone per addizione, l’impronta post-operatoria delle cavità, necessaria al laboratorio per eseguire i manufatti, che decidiamo di realizzare in composito.
La scelta del composito, come alternativa, alla ceramica è dettata dalla situazione clinica e dalla presenza di numerosi studi che dimostrano che ceramica e composito hanno un ottimo comportamento nel tempo; i compositi, inoltre, hanno un costo minore e rendono più semplici eventuali riparazioni.
Prima di dimettere il paziente realizziamo dei restauri provvisori con un materiale monocomponente e fotoindurente, aventi lo scopo di proteggere gli elementi dentari nei giorni che intercorrono tra la seduta dedicata alla presa dell’impronta e quella in cui avverrà la cementazione dei restauri indiretti.
Nella seconda seduta, fissata a distanza di una settimana, vengono rimossi i restauri provvisori e, dopo aver isolato il campo con la diga di gomma, si procede alla prova degli intarsi.
Gli intarsi e la cavità vengono poi detersi con uno spazzolino che veicola un impasto composto da polvere di pomice, alcol e sapone neutro e quindi risciacquati; sull’intarsio in composito viene applicato un silano per assicurare un miglior legame adesivo ed in seguito il bonding, senza polimerizzarlo. La procedura di cementazione adesiva viene effettuata su un elemento dentario per volta e viene svolta mediante il tradizionale adesivo a tre passaggi: si applica il mordenzante proteggendo gli elementi contigui, si sciacqua, si aplica il primer ed infine il bonding, senza polimerizzarlo.
Per colmare l’interfaccia intarsio-dente utilizziamo i tradizionali compositi fotopolimerizzabili preriscaldati: è stato dimostrato come il preriscaldamento aumenti il grado di conversione del monomero, che migliora le proprietà dell’agente cementante, e assicura una miglior fluidità, maneggevolezza e una diffusione omogenea del materiale. Una volta applicato il composito sull’intarsio, questo viene inserito nella cavità con una pressione energica e costante per favorirne il completo adattamento. Dopo aver rimosso gli eccessi di composito con una sonda e del filo interdentale, il composito viene fotopolimerizzato: il manufatto, in funzione degli spessori uniformi, verrà facilmente attraversato dalla luce della lampada polimerizzatrice e non sarà soggetto microfratture in fase di cementazione.
L’interfaccia intarsio-dente viene rifinita e lucidata con gommini con gradi di abrasività decrescenti: i restauri indiretti, cosi come i diretti, mostrano un ottimo adattamento marginale, e si integrano correttamente dal punto di vista morfologico e funzionale (Figg. 24, 25).
Quadrante 4
L’ultimo quadrante (Figg. 26, 27, 28) viene riabilitato, come il primo e il secondo, interamente con tecniche dirette, con il fine di raggiungere tutti quelli che dovrebbero essere gli obiettivi di un corretto ripristino dentale, ovvero:
_ il rispetto dell’ampiezza biologica, intesa come adeguata distanza tra il margine cervicale della cavità e il complesso di attacco;
_ l’ottenimento di una corretta funzione occlusale;
_ la realizzazione di un ottimo sigillo marginale coronale, imprescindibile garanzia per la durata del restauro;
_ il raggiungimento di un buon risultato estetico.
Tutti questi obiettivi sono perseguibili utilizzando correttamente i materiali compositi a nostra disposizione, in modo da sfruttarne al meglio tutte le proprietà.
In tutti restauri diretti, dopo aver eseguito le procedure volte a sviluppare l’adesione, applichiamo sul fondo cavitario un materiale flowable a basso modulo di elasticità che, fungendo da interfaccia tra adesivo e composito, consente di ridurre l’iniziale stress da polimerizzazione, in particolare in cavità dalla configurazione sfavorevole. Quindi disponiamo il composito in piccoli incrementi obliqui con spatoline e pennellini dedicati, apponendo prima le masse dentina (una per ogni cuspide), e in seguito le masse smalto, che vengono modellate in modo da ricreare fossette e solchi e possono essere caratterizzate mediante l’utilizzo dei supercolori.
A restauro ultimato si effettua la polimerizzazione finale dopo aver applicato sugli elementi dentari il gel di glicerina che, impedendo il contatto tra l’ultimo strato di composito e l’ossigeno, favorisce la completa polimerizzazione dell’ultimo strato di composito.
I restauri, se modellati senza creare debordi, devono solamente esser lucidati con gommini siliconici diamantati da lucidatura e brillantatura, utilizzati a basso numero di giri e con spray di acqua e infine mediante spazzolini impregnati con un agente di lucidatura al carburo di silicio, incorporato nelle setole stesse (Fig. 29).
Una volta rimossa la diga devono essere verificati i contatti occlusali ed è consigliabile escluderli se situati nell’interfaccia dente-restauro. Devono essere controllate l’intercuspidazione massima e i movimenti di lateralità lavorante e non lavorante, per evitare di introdurre interferenze occlusali. Dalla fotografia del caso finito si nota come i tessuti gengivali abbiano ritrovato una restituzio ad integrum e la stessa affermazione, fra virgolette, si può fare per i tessuti duri dentali (Fig. 30). Per ottenere una buona salute gengivale dobbiamo curare la chiusura marginale dei nostri restauri, i profili di emergenza e le aree di contatto.
Conclusioni
I dati in letteratura in tema di odontoiatria conservatrice, supportano, in presenza di cavità di ampie dimensioni, un approccio di tipo conservativo sia diretto che indiretto: la scelta fra l’uno o l’altro sarà guidata dalla quantità di sostanza dentale residua, dalla presenza di cavità multiple all’interno della stessa emiarcata e dall’abilità clinica dell’operatore, che deve agire sempre con coscienza e deve rispettare protocolli rigidi supportati dalla letteratura, in modo da poter ridurre le variabili in grado di determinare errori e da poter assicurare al paziente risultati a lungo termine. Le immagini conclusive di questo articolo dimostrano come sia possibile raggiungere, con le moderne tecniche conservative, tutti quelli che dovrebbero essere gli obiettivi di un corretto ripristino dentale:
_ quello biologico, inteso come adeguata distanza tra il margine di cavità cervicale correttamente ripulito dalla carie e il complesso di attacco;
_ occlusale, che presuppone l’esecuzione di restauri in grado di conferire stabilità all’occlusione stessa, in assenza di precontatti e/o di interferenze in lateralità e protrusive.
_ estetico, con restituzio ad integrum dei tessuti duri dentali e di quelli molli, che hanno ridonato alla visione intraorale l’estetica bianca e quella rosa (Figg. 31a, b, 32a, b, 33a-d, 34a-d, 35a-d).
Non va dimenticato infine che, per far perdurare nel tempo i risultati derivanti dalla nostra riabilitazione, è sempre necessario un programma di mantenimento mirato alle esigenze del paziente, associando sedute di igiene professionale, effettuate attraverso i richiami periodici, ad una corretta igiene domiciliare.
Bibliografia
1. Brenna F, Breschi L, Cavalli G, Devoto W, Dondi Dall’Orologio G, Ferrari P, Ferraris F, Fiorini A, Gagliani M, Manfrini M, Manfrini G, Marcoli A, Massai L, Monari A, Nuvina M, Oddera M, Palazzo M, Pansecchi D, Patroni S, Prando G, Robello C, Spreafico R, Tinti C, Veneziani M. Odontoiatria restaurativa: Procedure di trattamento e prospettive future.
2. Spreafico RC, Roulet JF. Posterior composite restorations: direct or indirect technique. In Roulet JF, Kappert HF, eds. Statements: diagnostics and therapy in dental medicine today and in the future. Quintessence, London 2009: 69-80.
3. Van Dijken JW. Direct resin composite inlays/onlays: an 11year follow-up. J Dent 2000 Jul; 28 (5): 299-306.
4. Spreafico RC, Krejci I, Dietschi D. Clinical performance and marginal adaptation of class II direct and semidirect composite restoratons over 3.5 years in vivo. J Dent 2005 Jul; 33(6): 499-507. Epub 2005 Feb 2.
5. Wassel RW, Walls AW, McCabe JF. Direct composite inlay versus conventional composite restorations: 5 year follow-up. J Dent 2000 Aug; 28 (6) 375-382.
6. Pallesen U, Qvist V. Composite resin fillings and inlays. An 11 year evaluation. Clin Oral Investig 2003 Jun;7(2):71-79. Epub 2003 May 10.
7. Mendonça JS, Neto RG, Santiago SL, Lauris JR, Navarro MF, de Carvalho RM.
Direct resin composite restorations versus indirect composite inlays: one-year results. J Contemp Dent Pract. 2010 May 1;11(3):025-32.
8. Van Dijken JW. Durability of resin composite restorations in high C-factor cavities: a 12-year follow-up. J Dent. 2010 Jun;38(6):469-74. Epub 2010 Mar 1.
9. Manhart J, Chen H, Hamm G, Hickel R. Buonocore Memorial Lecture. Review of the clinical survival of direct and indirect restorations in posterior teeth of the permanent dentition. Oper Dent. 2004 Sep-Oct;29(5):481-508.
10. Nakabayashi N, Kojima K, Masuhara E. The promotion of adhesion by the infiltrations of monomers into tooth substrate. J Biomed Mater Res 1982.
11. Pashley DH, Carvalho RM. Dentine permeability and dentine adhesion. J Dent 1997;25: 355-372.
12. Pashley Dh, Tay Fr, Yiu CKY, Hashimoto M, Breschi L, Carvalho R. Collagen degradation by host-derived enzymes during aging. J Dent Re 2004;83: 216-221.
13. Van Meerbeek B, De Munck J, Yoshida Y, Inoue S, Vargas M, Vijay P et al. Buonocore memorial lecture. Adhesion to enamel and dentin: current status and future challenges. Oper dent 2003-,28: 215-235.
14. Deliperi s, Bardwell DN. Clinical evaluation of direct cuspal coverage with posterior composite resin restorations. J Esthet Restor Dent 2006
15. Breschi L, Mazzoni A, Ruggeri A Jr, Cadenaro M, Di Lenarda R, Dorigo E. Dental adhesion review: aging and stability of the bonded interface. Dental Mater 2008; 24:90-101.
16. Manhart J, Hickel R. Longevity of Restorations. In: Wilson N, Roulet JF, Fuzzi M.Ad- vances in Operative Dentistry. Challenges of the future. Vol.2. Quintessence Publishing Co Inc, 2001; 16:237-304.
17. Bragger U, Lauchenauer D,Lang NP.Surgical lengthening of the clinical crown.J Clin Period 1992;19:58-63
18. Touati B, Miara P, Nathanson. Estetica dentale & Restauri in ceramica. Milano: Masson, 2000;11:259-91.
19. Dietschi D, Herzfeld D. In vitro evaluation of marginal and internal adaptation of class II resin composite restorations after thermal and occlusal stressing. Eu J Oral Sci 1998;106: 1033-1042.
20. Fuzzi M, Rapelli G. Survival rate of ceramic inlays. J Dent 1998 Sep; 26 (7): 623-626.
21. Daronch M, Rueggeberg FA, Hall G, De Goes MF. Effect of composite temperature on in vitro intrapulpal temperature rise. Dent Mater 2007;23:1283-1288.
22. Trujillo M, Newman SM, Stansbury JW. Use of near-IR to monitor the influence of external heating on dental composite photopolymeriza- tion. Dent Mater 2004;20:766-777.
L'articolo è stato pubblicato sul numero 1 di Cosmetic Dentistry 2013 Italy
Il composito nelle sue più recenti formulazioni (microibrido, nano particelle, nano ibrido), grazie alle sue proprietà biomeccaniche ed ...
Il composito nelle sue più recenti formulazioni (microibrido, nano particelle, nano ibrido), grazie alle sue proprietà biomeccaniche ed ...
Dalla metà degli anni Novanta fino ai giorni nostri l’evoluzione dei materiali e delle tecniche adesive ha notevolmente modificato ...
La paziente S.M. di anni 42, si presenta alla nostra osservazione per migliorare l’estetica del settore frontale (Fig. 1). All’esame obiettivo si ...
L’osservazione clinica dei segni e dei sintomi clinici è il punto di partenza per preparare un piano terapeutico efficace e duraturo che possa assicurare...
Dalla metà degli anni Novanta fino ai giorni nostri, l’evoluzione dei materiali e delle tecniche adesive ha notevolmente modificato ...
Dalla metà degli anni Novanta fino ai giorni nostri, l’evoluzione dei materiali e delle tecniche adesive ha notevolmente modificato ...
Un moderno materiale da restauro deve sicuramente avere delle specifiche proprietà ottiche e meccaniche per poter soddisfare le esigenze estetiche e ...
L’estetica riveste sempre più una connotazione di armonia ed equilibrio globale, certamente definiti da canoni condivisi e storicamente evolutisi, ma ...
L’evoluzione dei materiali compositi e delle tecniche adesive ha notevolmente cambiato l’approccio restaurativo nei settori latero-posteriori. I...
Live webinar
mer. 17 aprile 2024
18:00 (CET) Rome
Dr. Alexander Nussbaum Head of Scientific & Medical Affairs, Philip Morris GmbH, Dr. Björn Eggert
Live webinar
gio. 18 aprile 2024
0:00 (CET) Rome
Dra. Gabriella Peñarrieta Juanito
Live webinar
gio. 18 aprile 2024
17:00 (CET) Rome
Live webinar
lun. 22 aprile 2024
16:00 (CET) Rome
Prof. Dr. Erdem Kilic, Prof. Dr. Kerem Kilic
Live webinar
mar. 23 aprile 2024
19:00 (CET) Rome
Live webinar
mer. 24 aprile 2024
14:00 (CET) Rome
Dr. Yin Ci Lee BDS (PIDC), MFDS RCS, DClinDent Prosthodontics, Dr. Ghida Lawand BDS, MSc, Dr. Oon Take Yeoh, Dr. Edward Chaoho Chien DDS, DScD
Live webinar
mer. 24 aprile 2024
19:00 (CET) Rome



 Austria / Österreich
Austria / Österreich
 Bosnia ed Erzegovina / Босна и Херцеговина
Bosnia ed Erzegovina / Босна и Херцеговина
 Bulgaria / България
Bulgaria / България
 Croazia / Hrvatska
Croazia / Hrvatska
 Repubblica Ceca e Slovacchia / Česká republika & Slovensko
Repubblica Ceca e Slovacchia / Česká republika & Slovensko
 Finlandia / Suomi
Finlandia / Suomi
 Francia / France
Francia / France
 Germania / Deutschland
Germania / Deutschland
 Grecia / ΕΛΛΑΔΑ
Grecia / ΕΛΛΑΔΑ
 Italia / Italia
Italia / Italia
 Paesi Bassi / Nederland
Paesi Bassi / Nederland
 nordisch / Nordic
nordisch / Nordic
 Polonia / Polska
Polonia / Polska
 Portogallo / Portugal
Portogallo / Portugal
 Romania e Moldavia / România & Moldova
Romania e Moldavia / România & Moldova
 Slovenia / Slovenija
Slovenia / Slovenija
 Serbia e Montenegro / Србија и Црна Гора
Serbia e Montenegro / Србија и Црна Гора
 Spagna / España
Spagna / España
 Svizzera / Schweiz
Svizzera / Schweiz
 Turchia / Türkiye
Turchia / Türkiye
 Gran Bretagna e Irlanda / UK & Ireland
Gran Bretagna e Irlanda / UK & Ireland
 Internazionale / International
Internazionale / International
 Brasile / Brasil
Brasile / Brasil
 Canada / Canada
Canada / Canada
 America Latina / Latinoamérica
America Latina / Latinoamérica
 USA / USA
USA / USA
 Cina / 中国
Cina / 中国
 India / भारत गणराज्य
India / भारत गणराज्य
 Giappone / 日本
Giappone / 日本
 Pakistan / Pākistān
Pakistan / Pākistān
 Vietnam / Việt Nam
Vietnam / Việt Nam
 ASEAN / ASEAN
ASEAN / ASEAN
 Israele / מְדִינַת יִשְׂרָאֵל
Israele / מְדִינַת יִשְׂרָאֵל
 Algeria, Morocco & Tunisia / الجزائر والمغرب وتونس
Algeria, Morocco & Tunisia / الجزائر والمغرب وتونس
 Medio Oriente / Middle East
Medio Oriente / Middle East
:sharpen(level=0):output(format=jpeg)/up/dt/2024/04/Francesco_Riva.jpg)
:sharpen(level=0):output(format=jpeg)/up/dt/2024/04/DeFrancesco_4-1.jpg)
:sharpen(level=0):output(format=jpeg)/up/dt/2024/04/Distalizzazione.jpg)
:sharpen(level=0):output(format=jpeg)/up/dt/2024/04/Italian-researchers-test-11-new-3D-printing-materials.jpg)
:sharpen(level=0):output(format=jpeg)/up/dt/2024/04/40_DTI.jpg)





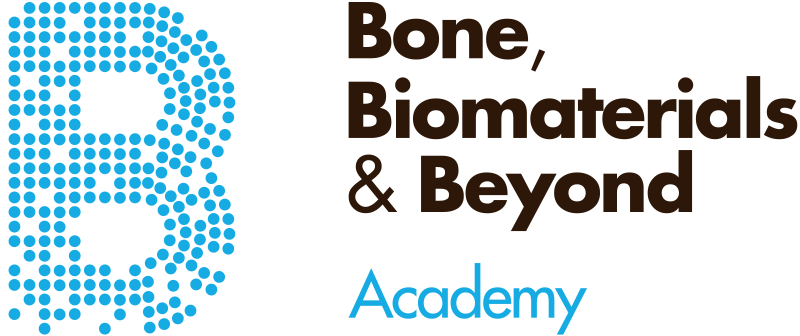

:sharpen(level=0):output(format=png)/up/dt/2010/11/Nobel-Biocare-Logo-2019.png)
:sharpen(level=0):output(format=png)/up/dt/2022/05/osstem_logo.png)
:sharpen(level=0):output(format=png)/up/dt/2023/03/ACTEON_NEW-logo_03-2024.png)
:sharpen(level=0):output(format=png)/up/dt/2014/02/Planmeca.png)
:sharpen(level=0):output(format=png)/up/dt/2019/04/logo.png)
:sharpen(level=0):output(format=png)/up/dt/2022/01/HASSBIO_Logo_horizontal.png)
:sharpen(level=0):output(format=jpeg)/up/dt/e-papers/338089/1.jpg)
:sharpen(level=0):output(format=jpeg)/up/dt/e-papers/336779/1.jpg)
:sharpen(level=0):output(format=jpeg)/up/dt/2024/02/DTIT_0224_page-1_page-0001.jpg)
:sharpen(level=0):output(format=jpeg)/up/dt/e-papers/334266/1.jpg)
:sharpen(level=0):output(format=jpeg)/up/dt/e-papers/332758/1.jpg)
:sharpen(level=0):output(format=jpeg)/up/dt/e-papers/331276/1.jpg)
:sharpen(level=0):output(format=jpeg)/up/dt/2017/01/1995c4fc124f47fc9fa1cccb008d148f.jpg)

:sharpen(level=0):output(format=jpeg)/up/dt/2024/04/Francesco_Riva.jpg)
:sharpen(level=0):output(format=gif)/wp-content/themes/dt/images/no-user.gif)
:sharpen(level=0):output(format=jpeg)/up/dt/2017/01/6a33010f073801d7b1bd75c88a00fa23.jpg)
:sharpen(level=0):output(format=jpeg)/up/dt/2017/01/5e831d4e078f3ff1057bf9048aa0acae.jpg)
:sharpen(level=0):output(format=jpeg)/up/dt/2017/01/4b618c737e4d600b70b0818fab4dfb3c.jpg)
:sharpen(level=0):output(format=jpeg)/up/dt/2021/06/1-1.jpg)
:sharpen(level=0):output(format=jpeg)/up/dt/2023/07/Grassi_6.jpg)
:sharpen(level=0):output(format=jpeg)/up/dt/2017/01/ff204f827088010370e95608d38a16b2.jpg)
:sharpen(level=0):output(format=jpeg)/up/dt/2017/01/608d1b39323e536832afd3fb61647ad4.jpg)
:sharpen(level=0):output(format=jpeg)/up/dt/2018/01/web1a.jpg)
:sharpen(level=0):output(format=jpeg)/up/dt/2021/03/3web.jpg)
:sharpen(level=0):output(format=jpeg)/up/dt/2017/01/3cd0b50717166418141b45f8a163b2d4.jpg)
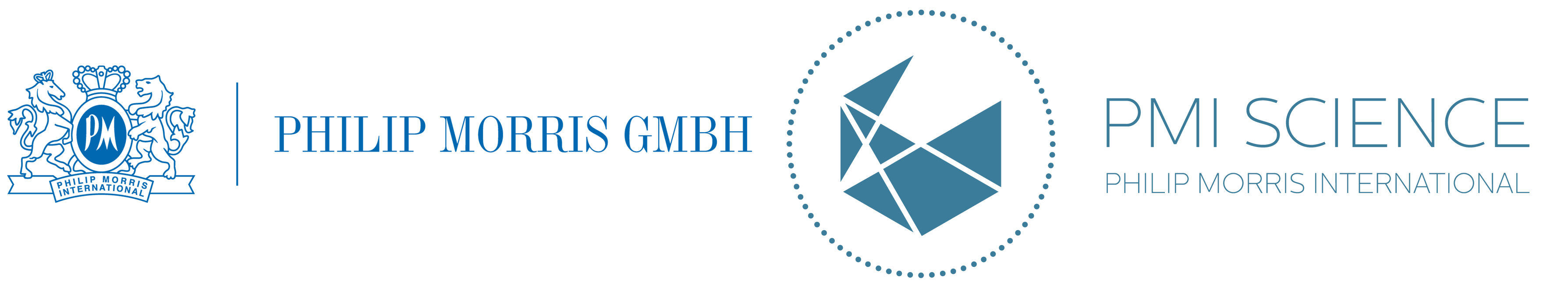








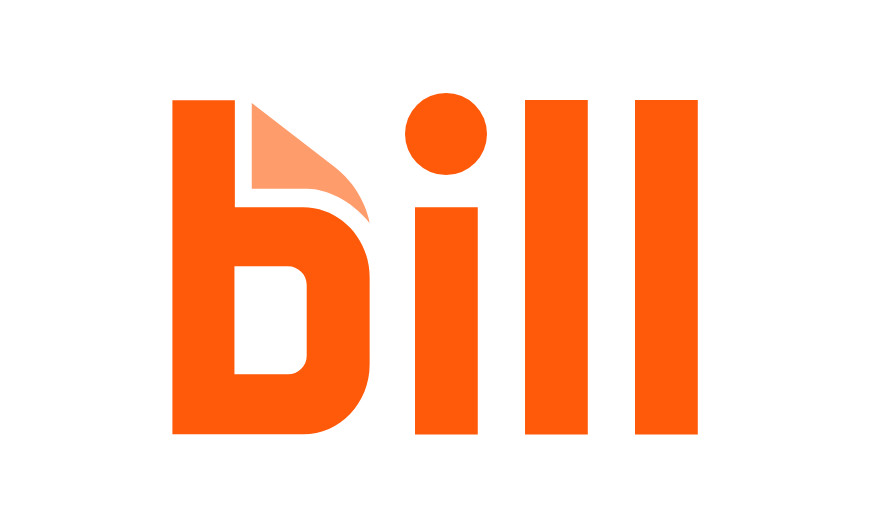

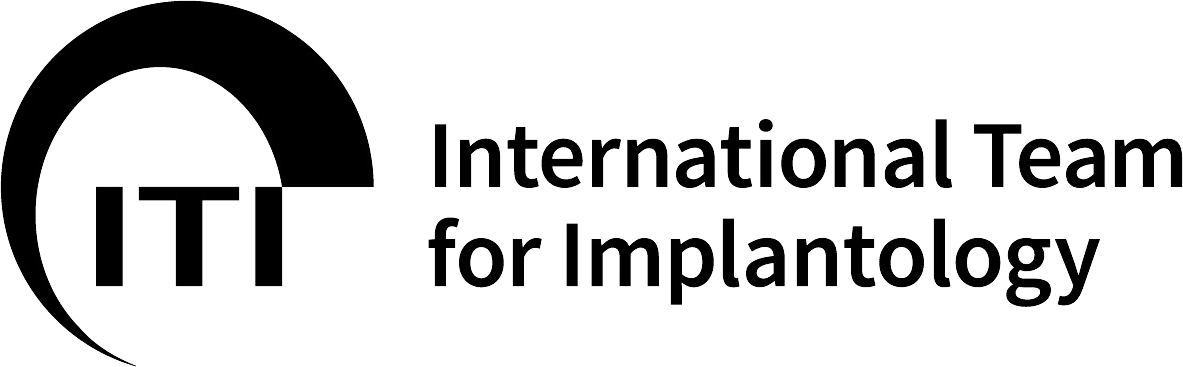




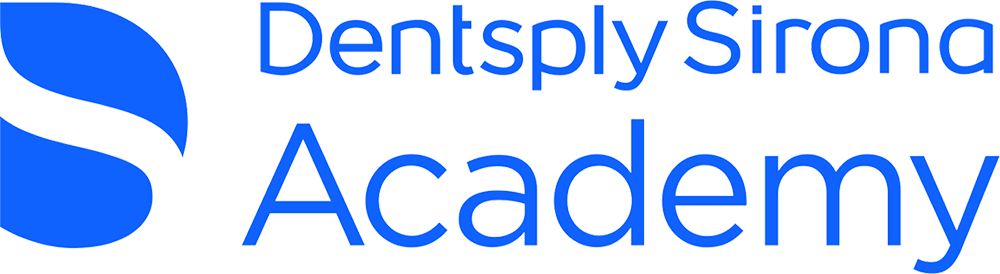

:sharpen(level=0):output(format=jpeg)/up/dt/2024/04/Francesco_Riva.jpg)
:sharpen(level=0):output(format=jpeg)/up/dt/2024/04/DeFrancesco_4-1.jpg)
:sharpen(level=0):output(format=jpeg)/up/dt/2024/04/Distalizzazione.jpg)
:sharpen(level=0):output(format=jpeg)/up/dt/e-papers/336779/1.jpg)
:sharpen(level=0):output(format=jpeg)/up/dt/2024/02/DTIT_0224_page-1_page-0001.jpg)
:sharpen(level=0):output(format=jpeg)/up/dt/e-papers/334266/1.jpg)
:sharpen(level=0):output(format=jpeg)/up/dt/e-papers/332758/1.jpg)
:sharpen(level=0):output(format=jpeg)/up/dt/e-papers/331276/1.jpg)
:sharpen(level=0):output(format=jpeg)/up/dt/e-papers/338089/1.jpg)
:sharpen(level=0):output(format=jpeg)/up/dt/e-papers/338089/2.jpg)
:sharpen(level=0):output(format=jpeg)/wp-content/themes/dt/images/3dprinting-banner.jpg)
:sharpen(level=0):output(format=jpeg)/wp-content/themes/dt/images/aligners-banner.jpg)
:sharpen(level=0):output(format=jpeg)/wp-content/themes/dt/images/covid-banner.jpg)
:sharpen(level=0):output(format=jpeg)/wp-content/themes/dt/images/roots-banner-2024.jpg)
To post a reply please login or register